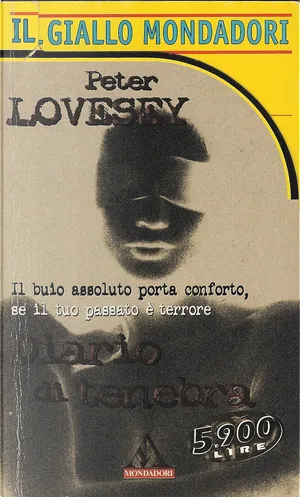E' da un po' di tempo che non riesco più a leggere un libro poliziesco, senza metterci del tempo: anni fa, li divoravo i libri, ora ci metto più tempo. Normalmente è un fatto comune alla mia età: più che alla trama, si perde tempo a vedere come il libro sia stato scritto, ci si sofferma sullo stile. Ma nel mio caso, la lentezza è stata dovuta ad altro fattore: che fosse un romanzo della Sayers. Non sono molto convinto di quello che diceva Edmund Wilson, parlando de
Il segreto delle campane, affermando che era" uno dei libri più noiosi che avesse letto", però un fondo di verità c'è: i libri della Sayers sono troppo ridondanti, ci sono tropppi dialoghi, laddove in lavori di altri scrittori, ce ne sono meno. Cioè c'è troppa atmosfera. E in questo suo esordio, "il troppo - mi verrebbe da dire - stroppia". Mi sarebbe piaciuto sapere il giudizio di Wilson a riguardo.
Whose Body?, è del 1923. E' l'esordio di Lord Peter Wimsey, rampollo dell'aristocrazia più esclusiva: secondogenito del Duca Mortimer Winsey e Honoria Lucasta Delagardie, Peter ha un fratello maggiore, Lord Gerald, ed una sorella, Lady Mary. Ha partecipato alla Prima Guerra Mondiale con il grado di Maggiore, riportando un trauma nervoso a causa dello scoppio di una granata, e al rientro si è stabilito in un appartamento, assieme al suo attendente in guerra, diventato il suo fedele maggiordomo Bunter, oltre assistente nelle indagini ed esperto di fotografia, tanto da aver trasformato una stanza in un laboratorio fotografico di tutto rispetto. L'amico e spalla nelle varie inchieste di cui è protagonista , è il fedele Ispettore Parker di Scotland Yard. Tutti questi personaggi compaiono in questo primo suo esordio.
Alfred Thipps è un piccolo architetto che si sta occupando della riparazione del tetto di una chiesa, ed è conosciuto dalla madre di Lord Peter. E' lei ad informarlo che l'esterrefatto Thipps ha trovato nella vasca del suo bagno, un cadavere : un uomo completamente nudo, ma con indosso solo un paio di pince-nez. Sarebbe la notizia del giorno, se proprio quella mattina i valletti non avessero denunciato la somparsa di Sir Reuben Levy, un finanziere di origini ebraiche molto noto nella City, allontanatosi da casa sua, nel cuore della notte, completamente nudo.
Ci si chiede subito se il cadavere nella vasca da bagno non sia quello di Levy: una rassomiglianza c'è, ma se l'esame della polizia non tende ad escluderlo, quello che attua Wimsey lo esclude a priori: anche se sembrerebbe appartenente ad un uomo in buono stato di salute, Wimsey appura calli ai piedi e una pedicure molto essenziale, che rivelano il fatto che era un tipo che camminava molto, cosa incompatibile con Levy, tipo abituato alla carrozza; e denti guasti e ingialliti dal tabacco, incompatibili con gente abituata ad andare dal dentista. Per di più prima di essere lasciato nudo nella vasca, era stato
sbarbato, ma non tanto accuratamente da non lasciare i rimasugli in
peli, cosa che Wimsey trova. Un controsenso c'è: se vi sono questi particolari che farebbero pensare ad una persona di assai modeste e trasandate condizioni (anche le orecchie intasate dal cerume), il volto appare sbarbato di fresco e i capelli odorano di lozione. In altre parole, quel cadavere fa parte di una messinscena. Ma la prova sicura che si tratti di altra persona è data dalla constatazione di qualcosa che qui c'è ma se fosse il cadavere di Levy non dovrebbe esserci: la circoncisione del prepuzio, che viene però lasciata all'intelligenza del lettore. Infatti Parker ad un certo punto dice nella primissima edizione: Sir Reuben is a pious Jew of pious parents, and the chap in the bath obviously isn't .
Da qui si snoda tutta una indagine che Wimsey è chiamato a fare, da sua madre, per scagionare dall'accusa di omicidio il povero Thipps, chiamato in causa da Sugg, un ispettore di polizia, che non sa guardare troppo al di là del suo naso. Sugg invero prima di accusare Thipps di omicidio, ha pensato che il cadavere senza nome forse fosse di un senza tetto, magari uno dei cadaveri forniti al St.Luke Hospital, per le dissezioni, dove opera il famoso chirurgo Sir Julius Freke, peraltro amico dei Levy, e Ma è lo stesso chirurgo, accorso sul luogo del ritrovamento a non riconoscere in esso nessuno dei cadaveri forniti al suo Ospedale. Il morto, è morto per un violento colpo all'altezza della 4^-5^ vertebra. Non si sa se sia stato ucciso oppure se sia morto per incidente, ma se non è stato Thuipps a depositarlo là, e poi perchè, e perchè poi se davvero fosse stato lui avrebbe mai messo in moto un meccanismo capace di farlo incriminare, chi mai è riuscito a depositarlo lì? E come ha fatto? E' entrato dalla porta di casa, trascinandolo fino al bagno, oppure lo ha depositato lì passando dal tetto? Possibile che qualcuno si sia issato fino al piano della casa dei Thipps dove sta il bagno, portando con sè un cadavere, e lo abbia depositato nella vasca da bagno? Vicino al palazzo, una serie di case e di cortili vari, compresa la mole del St.Luke Hospital. Una ipotesi non meno strampalata di quella secondo cui il necroforo avrebbe portato son sè un cadavere nudo, facendolo passare dalla porta di casa e lo avrebbe trascionato su per le scale sino al bagno. Eppure quel cadavere in quel bagno ci è finito !
Lord Peter si occupa di quel cadavere per capire chi sia, ma nello stesso tempo indaga sulla scomparsa di Sir Reuben, perchè quei due casi, pur lontanissimi hanno un medesimo comune denominatore: Sir Reuben si è allontanato da casa sua lasciando tutti gli abiti a casa, e quindi presumibilmente uscendo nudo, e quel cadavere ignoto nella vasca da bagno, anche quello è nudo. Su questa traccia debolissima, si instaura una indagine a 360° che si appunta su matrimoni falliti, su azioni peruviane comprate da un ignoto compratore (non Sir Levy ma) Mr. Milligan (un suo concorrente finanziere), su Mr. Crimplesham, noto avvocato, possessore del pince-nez trovato sul cadavere della vasca da bagno, e su delle misteriose serie di impronte lasciate da un guanto di gomma usato da un misteriso visitatore, entrato in casa di Sir Reuben la notte della scomaparsa di questi, che indossava i suoi stessi vestiti, e che ha dormito nel suo letto, e quelle lasciate da chi ha depositato il misteriso cadavere nella vasca da bagno di Thipps, che sembrano provenire dal medesimo guanto: in altre parole un misterioso individuo avrebbe portato un cadavere in un appartamento non suo, e fatto sparire un uomo da un altro, indossando poi si suoi vestiti e rientrando in casa di costui indossando gli abiti dell'altro, perchè magari il persdonale di servizio, la cuoca, lo identificasse falasamente come Reubenm e quindi facendo supporre che Reuben a sua volta fosse stato ucciso (lasciando però un misterioso capello rosso). Da queste misteriose impronte e da un misterioso capello rosso, partirà una indagine che porterà ad uno sviluppo finale imprevisto e alla cattura di un diabolico assassino, pazzo criminale.
Il romanzo è affascinante, devo dirlo in tutta franchezza, e scritto in maniera sontuosa; i dialoghi sono la cosa più godibile del romanzo e si può dire che siano la base del plot, perchè dai dialoghi si irradia la verità della ricostruzione. Dialoghi + descrizioni = atmosfera. Quindi atmosfera in questo romanzo ve n'è a bizzeffe. Troppa quasi. E la cosa che salta agli occhi è che accanto a cose che hanno indubbiamente un valore nella detection, ve ne sono tantissime che non ne hanno. Mi fa quasi dire che Dorothy Sayers, allungando il brodo della trama, facendo agire e comportarsi in maniera così vezzosamente snob un aristocratico londinese, con le sue fisime e le sue manie, lo ha fatto in maniera voluta, perchè così in un mare di scuiocchezze ma anche di indizi criptici, nasconde quello che poi lo porterà alla soluzione del mistero.
Manca tuttavia in questo romanzo lo shock della scoperta dell'assassino in un finale convulso, perchè l'assassino lo si scopre quasi trenta pagine prima della fine: è un romanzo degli anni '20, è bene sottolinearlo, non degli anni '30; è un romanzo in cui l'avventura ha ancora un suo peso, in cui la deduzione è massima (e deriva sicuramente da Sherlock Holmes: le impronte digitali, i capelli, le macchie di fango, la forma umana incavata nel letto di Sir Reuben di altezza diversa da lui e misurata da Wimsey) ma l'introspezione psicologica è minima, in cui come in altri casi, la vicenda delittuosa ha la sua fine prima della fine del romanzo e poi segue solo la ricostruzione dei fatti che l'hanno provocata, per mano di Wimsey ma anche sulla base della confessione del suo stesso assassino (in qualche modo rammenta l'epilogo di The Valley of Fear di Conan Doyle o The Murders in Praed Street, di John Rhode). E' un romanzo in cui i luoghi hanno una importanza massima, proprio perchè dal loro raffronto si possono evincere indizi che portano in un'unica direzione.
La traduzione pubblicata da Polillo si basa non sulla primssima edizione del 1923 (rarissima) ma su uan posteriore, e questo ha la sua importanza: e come l'idea alla base del romanzo era stata cambiata in un secondo tempo (inizialmente ad essere ritrovato nudo in una vasca non era un cadavere maschile ma uno femminile di un soggetto grasso), così fu espunta dalla prima edizione tutta una serie di riferimenti e di allusioni antisemite (i critici hanno molte volte dibattuto sulla natura dell' antisemitismo nella Sayers, forse solo un suo modo di tratteggiare gli ebrei nell'ambito della società inglese del tempo) che in questa traduzione si notano. Oltre all'affermazione di Parker già citata prima, il termine Jew o Jews compare parecchie volte, se non in senso dispregiativo almeno in uno alquanto curioso, per es. nel terzo capitolo:
Of course we’re all Jews nowadays, and they
wouldn’t have minded so much if he’d pretended to
be something else, like that Mr. Simons we met at
Mrs. Porchester’s, who always tells everybody that he
got his nose in Italy at the Renaissance, and claims
to be descended somehow or other from La Bella
Simonetta—so foolish, you know, dear—as if anybody
believed it; and I’m sure some Jews are very
good people
“I agree with you, Mr. Graves—his lordship and
me have never held with being narrow-minded—why,
yes, my dear, of course it’s a footmark, this is
the washstand linoleum. A good Jew can be a good
man, that’s what I’ve always said. And regular hours
and considerate habits have a great deal to recommend
them. Very simple in his tastes, now, Sir
Reuben, isn’t he? for such a rich man, I mean.”
La stessa affermazione di Parker che tratteggia qualcosa che può indirizzare ad un soggetto ebreo, viene in una successiva edizione sostituita da altra espressione che non fa riferimento alla razza ebraica: But as a matter of fact, the man in the bath is no more Sir Reuben Levy than than Adolf Beck, poor devil, was John Smith" . Tutto ciò probabilmente per non essere tacciati di antisemitismo.
Sul personaggio di Wimsey si può anche dire qualcos'altro.
Innazitutto, come lui si ponga nei confronti dell'indagine criminale. E' un modo di fare, che parecchi autori britannici hanno usato coi loro personaggii, quasi sempre nei romanzi di esordio o comunque nella prima prodizione: mi ricordo che anche Carr fa dire la stessa cosa con Bencolin. Lord Peter Wimsey, conversando con Parker, esprime il suo modo di gestire una indagine criminale e il suo modo di approcciarsi ai criminali.
In sostanza Lord Peter "riconosce che per lui è un gioco, che per lui è eccitante iniziare ad occuparsi di un caso ma che poi quando l'indagine si sostanzia nell'accusa di qualcuno che potrebbe essere imprigionato o sentenziato a morte, la sua gioia, il suo gioco cessa, e non vuole neanche più intromettersi perchè per lui questo non è un lavoro (come per Parker) ma una evasione, un gioco. Andando avanti nel discorso, è Parker che rimprovera all'amico, il suo infantile modo di comportarsi. Il delitto di Sir Reunben non è un gioco e quindi lui deve smetterla di presentare tutto come se fosse un gioco di marionette, ma un dramma umano la sui soluzione può essere anche la condanna di qualcuno. L'indagine per trovare un assassino non è uno sport, ma vita reale. la vita non è una partita di pallone" (cap. VII).
“D’you like your job?”
The detective considered the question, and replied:
“Yes—yes, I do. I know it to be useful, and I am
fitted to it. I do it quite well—not with inspiration,
perhaps, but sufficiently well to take a pride in it. It
is full of variety and it forces one to keep up to the
mark and not get slack. And there’s a future to it.
Yes, I like it. Why?”
“Oh, nothing,” said Peter. “It’s a hobby to me,
you see. I took it up when the bottom of things was
rather knocked out for me, because it was so damned
exciting, and the worst of it is, I enjoy it—up to a
point. If it was all on paper I’d enjoy every bit of it.
I love the beginning of a job—when one doesn’t
know any of the people and it’s just exciting and
amusing. But if it comes to really running down a
live person and getting him hanged, or even quodded,
poor devil, there don’t seem as if there was any excuse
for me buttin’ in, since I don’t have to make my
livin’ by it. And I feel as if I oughtn’t ever to find it
amusin’. But I do.” ....
...“Then why let your vainglorious conceit in your
own power of estimating character stand in the way
of unmasking the singularly cold-blooded murder of
an innocent and lovable man?”
“I know—but I don’t feel I’m playing the game
somehow.”
“Look here, Peter,” said the other with some earnestness,
“suppose you get this playing-fields-of-Eton
complex out of your system once and for all. There
doesn’t seem to be much doubt that something unpleasant
has happened to Sir Reuben Levy. Call it
murder, to strengthen the argument. If Sir Reuben
has been murdered, is it a game? and is it fair to treat
it as a game?”
“That’s what I’m ashamed of, really,” said Lord
Peter. “It is a game to me, to begin with, and I go on
cheerfully, and then I suddenly see that somebody is
going to be hurt, and I want to get out of it.”
“Yes, yes, I know,” said the detective, “but that’s
because you’re thinking about your attitude. You
want to be consistent, you want to look pretty, you
want to swagger debonairly through a comedy of
puppets or else to stalk magnificently through a
tragedy of human sorrows and things. But that’s
childish. If you’ve any duty to society in the way of
finding out the truth about murders, you must do it
in any attitude that comes handy. You want to be
elegant and detached? That’s all right, if you find
the truth out that way, but it hasn’t any value in itself,
you know. You want to look dignified and consistent—what’s
that got to do with it? You want to
hunt down a murderer for the sport of the thing and
then shake hands with him and say, ‘Well played—hard
luck—you shall have your revenge tomorrow!’
Well, you can’t do it like that. Life’s not a football
match. You want to be a sportsman. You can’t be a
sportsman. You’re a responsible person.”
“I don’t think you ought to read so much theology,”
said Lord Peter. “It has a brutalizing influence.”(chapter VII).
Lord Peter all'inizio della sua avventura di investigatore, è quindi ancora un dilettante, che si improvvisa detective per fuggire la noia e trovare una cura alle sue crisi nervose dovute a stress traumatico da bombardamento. Qui però quello che per lui è un gioco, per altri non lo è. In sostanza la tenzone, il duello che lui intende come inizialmente qualcosa di sportivo, per l'assassino non lo è. L'assassino ha fatto di tutto perchè i due fatti non fossero messi in relazione, il ritrovamento del cadavere sconosciuto e la sparizione di Reuben Levy, e le due situazioni che invece si intrecciano strettamente, metteranno in luce il piano diabolico di un assassinio perfetto o che sarebbe stato concepito per esserlo, ma che si inceppa, perchè l'assassino deposita il cadavere sconosciuto in casa di qualcuno che non sa essere vicino a Lord Peter Wimsey. Un piano calcolato al millesimo, si inceppa. E se vogliamo, è sì un piano diabolico, ma che Thomas De Quicey l'avrebbe definito sicuramente qualcosa di artistico, il cui movente non è altro che un matrimonio fallito: l'assassino avrebbe voluto sposare la moglie di Levy e quindi per anni, giorno per giorno medita vendetta, che si realizza finalmenter un giorno. E siccome per Lord Peter, almeno in questa sua prima grande fatica, l'indagine è stata un'evasione, un gioco, un duello, lui affronta l'assassino in un incontro a due, in cui entrambi sanno che il reciproco sa, eppure mascherano l'incontro come la molla per fare altro. Vi sono vari momenti durante il romanzo in cui i due vengono in contatto, e ce n'è uno in cui lui viene contattato da Parker (che non sa però di avere dinanzi l'assassino): anche in questi casi, l'assassino gioca con loro, un gioco mortale. E nel momento in cui lui rifiuta di fare quello che l'altro vorrebbe che facesse, ecco che tutto finisce, l'incontro finisce, e l'altro viene arrestato prima che possa uccidersi. Lascia però una confessione molto comoda, che lo incastra per sempre, e che se non ci fosse stata, lui, il responsabile, l'avrebbe fatta franca.
In sostanza però anche l'assassino ha visto il suo duello come una sfida sportiva, e come uno sportivo accetterebbe la sconfitta in uno sport con una stretta di mano e un abbraccio, così lui tende la sua mano, la confessione. Che lo farà impiccare. In questo il romanzo si riconosce opera degli anni '20.
Con il suo modo di trattare persone e situazioni, tra lo snob e
l'anticonvenzionale, Wimsey si avvicina notevolmente direi, ad un altro
personaggio di fiction, creato pressappoco in quegli anni, snob quanto
basta: Philo Vance. Tuttavia Philo Vance dall'alto della sua
enciclopedica conoscenza, è figlio di Nietzche, e del mito del
superuomo, e come tale disprezza il volgo, mentre Wimsey è un Lord, che
pur essendo altamente acculturato e versato a numerose conoscenze, pur
sembrando un aristocratico opposto al popolo, ne prende le distanze
numerose volte nel romanzo: notevole è il confronto con il fratello
maggiore, quando gli chiede l'auto, per esempio. O quando dovendo
presentarsi davanti alla Duchessa madre, lui vorrebbe andarvi con i
vestiti che ha addosso, mentre Bunter lo convince ( gli impone di) a
cambiarsi, in virtù di una microscopica macchiolina di grasso sul
tessuto dei pantaloni, causata da uno schizzo di latte, che potrebbe
scandalizzare la genitrice.
E il finale è davvero sopra le righe! Purtuttavia manca il pathos della cattura, presente in tutti i grandi romanzi degli anni '30, e questo è un grave handicap, che toglie molto alla soddisfazione della lettura.
Pietro De Palma